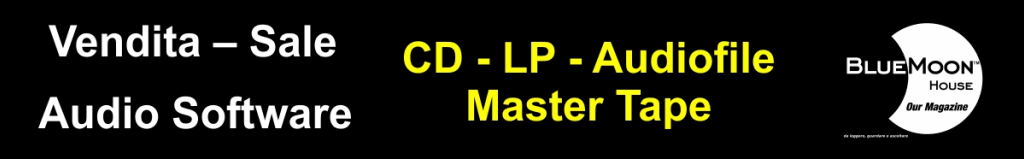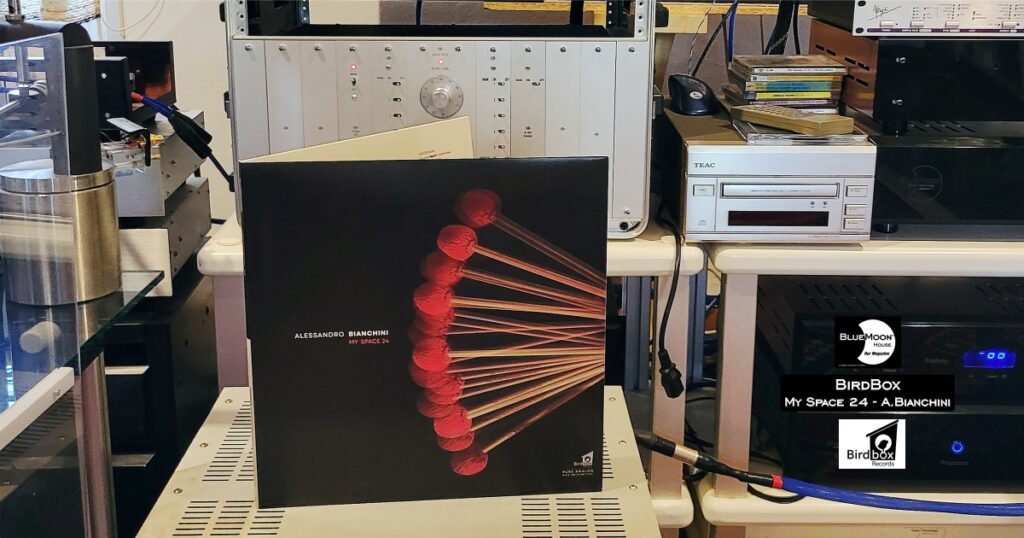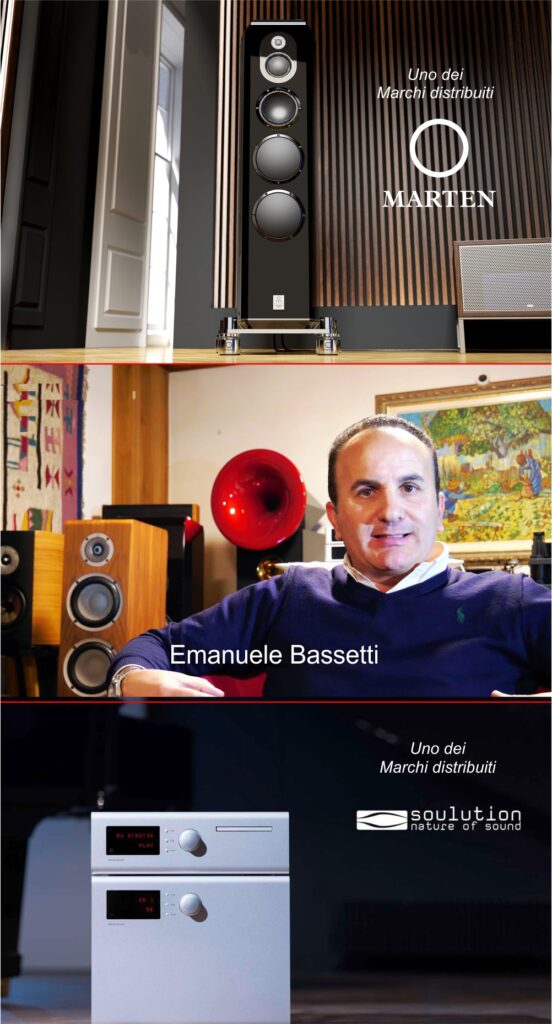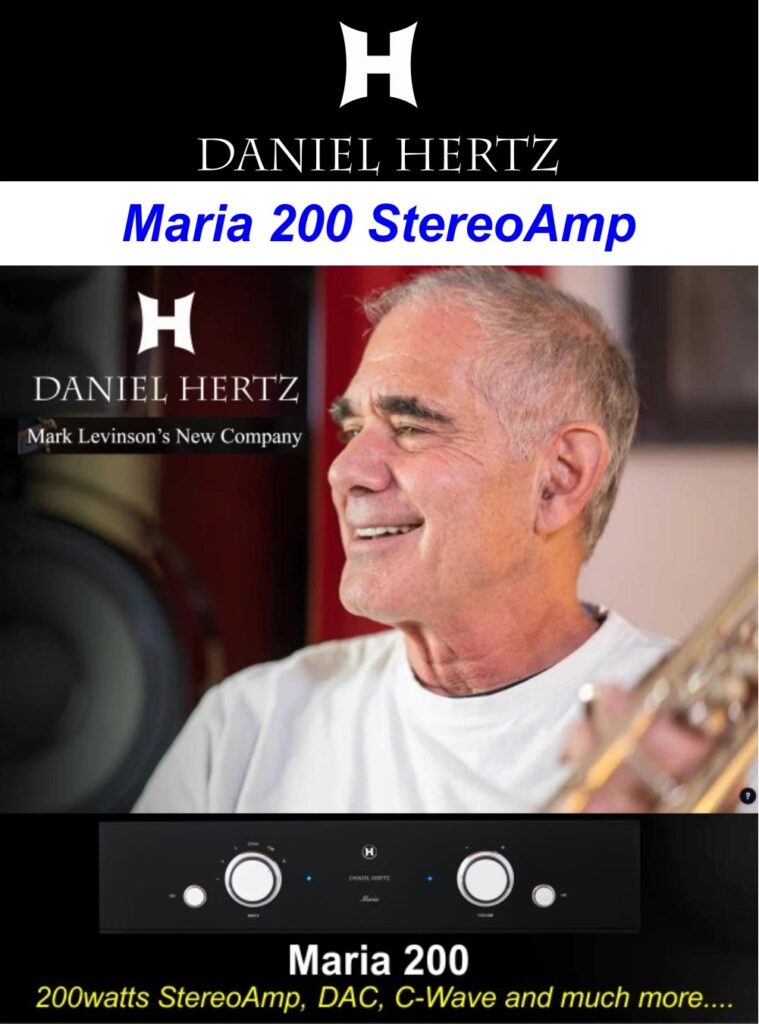La memoria delle emozioni 1°
Cari lettori,
con questo primo appuntamento della nostra nuova rubrica, vorrei cogliere l’occasione di presentarmi.
Sono Barbara Pasqualini, una biologa dalla formazione culturale eterogenea (la prima parte del mio percorso di studi è stato dedicato al settore umanistico) e con una grande passione per la musica. Essa occupa un ruolo fondamentale nella mia vita, come veicolo d’elezione, accanto alla letteratura, per comunicare e provare sensazioni ed emozioni uniche, in grado di far vibrare le corde più profonde del mio animo.
Mi trovo, però, più a mio agio con le parole, anche se la musica era, è e continuerà ad essere, per me, vita. Per questa ragione, probabilmente, esercita il mio interesse conoscere come essa si sia evoluta nel corso dei secoli. Come i popoli si siano cimentati e confrontati con questo espressione dell’animo umano. E come la abbiano plasmata sulla base della loro vita e dell’evoluzione che inevitabilmente accompagna ogni processo storico.
E’ qui che arrivano i miei primi ringraziamenti: al Direttore Editoriale, Bruno Fazzini e a quello Tecnico, Massimo Piantini, di Vintage Review, che mi hanno accolto tra loro e mi hanno offerto uno spazio, per provare a condividere con voi, cari lettori, questa mia passione.
Il mio progetto è ripercorrere e riscoprire con voi alcuni aspetti della storia della musica, dalle sue origini ai giorni nostri, proponendoli in varie puntate, sulla base delle testimonianze che i vari popoli ci hanno lasciato e di ciò che se ne può desumere da altre espressioni artistiche, quali la letteratura, le arti figurative, ecc.
Fig 1: “La Musica”, dipinto ad olio su tela (260 x 389 cm) realizzato da Henri Matisse nel 1910 (Museo dell’Ermitage” – San Pietroburgo). Fin dalla notte dei tempi, il suono è stato ritenuto di origine sacra e la stessa musica considerata qualcosa di potente e di enigmatico.
La memoria delle emozioni 1°
Le origini della musica
La musica esiste da prima ancora che ne rimanesse traccia storica. Non c’è stata civiltà che prima o poi non abbia sviluppato un proprio sistema musicale, o che non ne abbia adottato uno, seppure adattandolo alle sue necessità oppure ai suoi gusti.
La parola musica ha già un suo speciale fascino insito nel nome: deriva dalla parola greca moysa, “musa”. Originariamente il termine non indicava una particolare arte, bensì tutte le arti delle Muse (che come sappiamo erano nove e ognuna rappresentava un’arte in particolare), e si riferiva a qualcosa di perfetto ed ideale.

Le nove Muse: Clio, la storia; Thalia, la commedia; Erato, la poesia amorosa; Euterpe, la poesia lirica;
Polyhymnia, il mimo; Calliope, la poesia epica; Terpsichore, la danza; Urania, l’astronomia; Melpomene, la tragedia.
 |
|---|
La memoria delle emozioni 1°
L’origine della musica si perde nella notte dei tempi. Varie e controverse, infatti, sono le opinioni sulle origini di quest’arte. Secondo alcuni filosofi greci, quali Democrito ed Epicuro, la musica sarebbe nata negli uomini dal desiderio di imitare gli uccelli che cantano; questa teoria fu sviluppata e sostenuta dopo molti secoli, nell’ottocento, dal naturalista britannico Charles Darwin. Carl Stumpf, filosofo e psicologo tedesco vissuto tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento, invece, sosteneva che l’idea del canto venne dalle esclamazioni di diverso timbro, che servivano come richiamo agli uomini primitivi. Altri musicologi, come Bucher e Wallaschek, contemporanei di Stumpf, consideravano soprattutto il ritmo come punto iniziale di qualsiasi svolgimento musicale. La loro teoria è nota, infatti, come “Teoria del ritmo”.
Secondo altri la musica nacque semplicemente come espressione di sentimenti.
Prevale generalmente l’opinione che la musica vocale abbia preceduto quella strumentale; così, fra i primi canti, possiamo annoverare le ninne nanne cantate dalle madri nelle tenebre delle caverne, le canzoni che hanno celebrato la gioia del lavoro, oppure un incitamento ad esso, altre ancora con riferimenti ad avventure guerresche. L’origine della musica strumentale è certamente da ravvisare nel battito ritmico delle mani e dei piedi, nella percussione ritmica di oggetti metallici o lignei di varie forme, e nella graduata uscita del nostro soffio da canne vuote. Dopo le prime esperienze vocali, infatti, è assai probabile che gli strumenti abbiano esercitato un’azione più decisiva della voce umana, per la formazione dei sistemi rudimentali e dei primi rapporti sonori. L’incanto che si sprigiona dai suoni, ispirò molte leggende sulla origine degli strumenti e sulle prime espressioni liriche.
La memoria delle emozioni 1°
Gli scavi archeologici sul periodo paleolitico hanno portato alla luce vari strumenti a percussione che venivano utilizzati in misura maggiore dai cacciatori, tra questi troviamo: i sonagli (fig.4a). Successivamente i primi strumenti a fiato: flauti a tacca, flauti a fessura (fig.4b), trombe ricavate da conchiglie, ossa e corna animale.
Da: http://stec-174802.blogspot.it/2011/04/musica-preistorica.html
La musica nel “Mondo antico”
Il problema della determinazione dell’epoca che ha visto nascere la musica è ovviamente connesso con la definizione di musica che si sceglie di adottare. Mentre, infatti, per avere un sistema teorico di organizzazione dei suoni, collegato a precisi riferimenti estetici, dobbiamo attendere l’antica Grecia, per la prima comparsa di singoli ingredienti, come la produzione volontaria, anche tramite strumenti, di suoni da parte dell’uomo, dobbiamo risalire al paleolitico.
Alcune testimonianze in questo senso possono essere dedotte da numerosi ritrovamenti in osso e in pietra interpretati come strumenti musicali. Tali sono, ad esempio, gli zufoli magdaleniani (il Magdaleniano (18-17.000 – 11-10.000 anni fa, verso la fine dell’ultima glaciazione) è l’ultima cultura del Paleolitico superiore europeo) di Roc de Mercamps, o i litofoni neolitici scoperti nelle vicinanze di Dalat (Vietnam).
In mancanza di testimonianze dirette o mediate, qualche ipotesi sulla forma che assumeva la musica primitiva può anche essere dedotta dall’osservazione di popoli il cui stadio di sviluppo è ancora simile a quello delle culture preistoriche, ad esempio gli indios brasiliani, gli australiani aborigeni e alcune popolazioni africane.
Si può presumere che le primissime forme di musica siano nate soprattutto dal ritmo: magari per imitare, battendo le mani o i piedi, il cuore che batte, il ritmo cadenzato dei piedi in corsa, o del galoppo; o magari alterando, per gioco e per noia, le fonazioni spontanee durante un lavoro faticoso e monotono, come per esempio il pestare il grano raccolto per farne farina, o il chinarsi per raccogliere piante e semi, ecc. Per questi motivi, e per la relativa facilità di costruzione, è molto probabile che i primi strumenti musicali siano stati strumenti a percussione, e presumibilmente qualche variante di tamburo.
Tra gli strumenti più antichi ritrovati vi è infatti il tamburo a fessura, un cilindro cavo, con una fessura longitudinale lungo la superficie esterna, che veniva suonato percuotendolo con le bacchette sulla fessura stessa. Le versioni più antiche e primitive ritrovate consistono in un tronco cavo, privo di fessura ma appoggiato trasversalmente sopra una buca nel terreno, che forse veniva utilizzato dai suonatori percuotendolo con i piedi mentre lo sormontavano.
(L’arte musicale attraverso i secoli – G.Romano)
La memoria delle emozioni 1°
Manifestazioni musicali degli antichi popoli orientali
Musica nel vicino Oriente
Gli scavi del cimitero reale di Ur e l’iconografia musicale con cui è riccamente decorata l’architettura della prima Mesopotamia storica lasciano intendere che la musica era probabilmente molto importante nelle forme rituali tipiche della civiltà sumera. Esemplari di bassorilievo del Louvre, provenienti da Lagash, mostrano ad esempio strumenti cordofoni simili all’arpa.
Egiziani
Tra le prime civiltà di cui si hanno testimonianze musicali c’è quella egizia, dove la musica aveva un ruolo molto importante: la leggenda vuole che sia stato il dio Thot a donarla agli uomini.
Nell’antico Egitto, la musica aveva sia funzioni religiose (veniva infatti utilizzata nelle cerimonie sacre), sia di divertimento e svago.
Queste civiltà conoscevano già i principali intervalli fra i suoni (quinte, quarte, ottave), che erano usate come base per alcuni sistemi di scale. Da uno studio di Sachs (etnomusicologo ed organologo tedesco, 1881-1959) sull’accordatura delle arpe è emerso che gli Egizi utilizzavano una scala pentafonica discendente e che conoscevano la scala eptafonica. Dai sette toni della scala, corrispondenti ai sette pianeti, essi facevano derivare sette tonalità. La casta sacerdotale custodiva gelosamente il patrimonio della teoria musicale, a cui attinse Pitagora (570 a.C. – 495 a.C.), quando diede le basi al sistema musicale greco. Erodoto (484 a.C. – 425 a.C.) parla di un antico canto egizio, “Il canto di Maneros” che strappava le lacrime.
I disegni delle tombe e quelli degli obelischi, ci tramandano le figure di molti strumenti, fra cui il nefer, una specie di liuto, con il manico grande, e l’arpa chiamata tebuni. Tra gli strumenti utilizzati dagli Egizi, si trovano i crotali, il sistro, uno strumento idiofono, legato ad Hathor, la tromba, utilizzata in guerra e sacra ad Osiride, i tamburi, il liuto ed il flauto, sacro ad Amon. Altro strumento musicale assai presente e caratteristico della civiltà egizia è l’arpa arcuata, con un’ampia cassa armonica.
Strumenti più sofisticati dovettero attendere più a lungo. I primi ad apparire dopo le percussioni furono gli strumenti a fiato (flauto, corno) e a corde (lira e cetra), di cui esistono testimonianze greche, egizie e mesopotamiche anteriori al X secolo a.C.
Il testo di questo canto è stato così interpretato: “Battete per voi, o buoi. La paglia è vostra, il grano è per il padrone…” (L’arte musicale attraverso i secoli – G.Romano)
Musici di Amon, Tomba di Nakht, Diciottesima dinastia, Tebe.
Assiri e Babilonesi
Della pratica musicale presso gli Assiri non si conosce quasi nulla, sembra avesse specialmente il ruolo di rallegrare i banchetti. Fra gli strumenti musicali, flauti e tamburi, primeggiava la sambuca, una specie di piccola arpa.
Ebrei
Gli Ebrei coltivavano la musica con grande interesse e la associavano ai principali atti della vita religiosa e civile, pubblica e privata, dimostrando di apprezzare altamente il suo potere emotivo.
La fonte di notizie, per questo popolo, è la Bibbia. Gli Ebrei consideravano la musica come espressione collettiva di preghiera, di giubilo o di dolore. La Bibbia parla ripetutamente di inni a Dio cantati “Nelle cetre e negli organi” e accenna anche a Tubalkain, fabbro, (Genesi versetto 4:22: “Gilla a sua volta partorì Tubalkain, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro. La sorella di Tubalkain fu Naama.”) che inventò il primo modo di accompagnare, con strumenti a percussione, il canto.
I salmi, divisi tra il sacerdote e il popolo, o tra due cori di popolo, venivano cantati su alcuni motivi designati, che ripetevano la stessa cadenza per ogni versetto. L’espressione musicale del popolo ebreo raggiunse il massimo splendore sotto i regni di Davide ( X secolo a.C., secondo re d’Israele) e Salomone (970-930 a.C., terzo re d’Israele), in cui migliaia di cantori venivano adibiti a cantare le lodi di Jehova. Dagli antichi testi ebraici si rileva che, con il solo suono dell’arpa, Davide riusciva a rendere meno tetri i pensieri del re Saul (1079-1007 a.C., primo re d’Israele).
Durante il periodo della Monarchia (1030-933 a.C.), nel Tempio echeggiavano inni intonati da numerosi corpi corali. La Bibbia ci tramanda anche il nome del primo musicista, in un riferimento che sembra alludere a un’epoca attorno al 3200/3300 a.C.: Jubal (Genesi versetto 4:21: “Il fratello di questi si chiamava Jubal: egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto.”). Costui era considerato il padre dei suonatori degli strumenti a fiato e a corda. Sembra che valente musico fu anche il re Salomone, a cui si attribuisce il “Cantico dei Cantici”. Questo popolo importò dall’Egitto le arpe, ma usò anche trombe, corde e timpani. Gli strumenti più in uso presso di loro furono: il kinnor, a corda, lo Schofar, a fiato, e il thof, a percussione.
Indiani
Gli Indiani ebbero fin dai tempi antichissimi un vero e proprio sistema musicale. La scala aveva sette note (come quella dei Persiani e degli Arabi), analogamente alla nostra, ma divisa in ventidue parti. Per abbreviazione ogni nota era denominata con la sillaba iniziale e ciascuna portava il nome di una delle sette Ninfe personificanti la musica.
(L’arte musicale attraverso i secoli – G.Romano)
L’intervallo tra due gradi successivi della scala era diviso in tre o quattro parti, chiamate sruti (somiglianti ai nostri semitoni) e la scala, mediante queste suddivisioni, risultava formata, come precedentemente menzionato, da una serie di ventidue suoni.
Il libro più antico, contenente la dottrina dei suoni musicali, era intitolato “Ragavibadha”.
Lo strumento nazionale era il vinà, una specie di grossa chitarra con sette corde distese su una canna di bambù, alle cui estremità stavano due zucche vuote per casse di risonanza, e diciannove ponticelli disposti a guisa di tastiera.
(L’arte musicale attraverso i secoli – G.Romano)
Arabi
Il sistema musicale degli Arabi era affine a quello degli Indiani. Essi però dividevano la scala in diciassette gradi. Gli Arabi coltivarono una musica ricca di fioriture, piuttosto melanconica nelle melodie e bizzarra nei ritmi.
Cinesi
I Cinesi adottarono il più antico sistema musicale: stimavano irresistibili gli effetti della musica, la quale può incitare alla virtù e corrompere i costumi. Custodi gelosissimi delle loro tradizioni musicali nazionali, essi conservano ancora dei trattati teorici compilati circa tremila anni fa.
La scala cinese era formata di cinque suoni a partire dal fa (fa-sol-la-do-re), ma con una progressione di toni. In seguito si aggiunsero i due semitoni mancanti e si ebbero dodici suddivisioni corrispondenti, nell’idea cinese, alle dodici lune dell’anno.
Le tonalità, che così si ottennero, furono chiamate liù.
Filosofi e imperatori scrissero inni e fino a pochi secoli fa la musica non fu lasciata all’iniziativa privata, ma come istituzione, fu sottoposta agli ordini del capo dello Stato. La scrittura musicale cinese si legge dal basso all’alto, da sinistra a destra. Fra gli strumenti caratteristici dei Cinesi si trovano il kin, una specie di lira dalle corde di seta, il king, formato da una serie di pietre sonore (per la precisione: piastre di pietra di diverse dimensioni, sospese a un telaio e percosse da una mazza) e il pi-pa, prediletto dagli esecutori. Da ricordare anche il gong, ancora in uso, uno strumento musicale a percussione principalmente costruito in metallo, formato da un grande piatto di rame, in genere di forma circolare. Il gong generalmente è uno strumento a suono indeterminato, anche se in alcuni metodi di percussione viene indicato solamente come strumento a suono determinato.
Cinesi e Giapponesi hanno solitamente musiche vivaci ed altre dolcissime; per i riti religiosi però preferiscono i ritmi assordanti dei gong o di altri strumenti a percussione.
Il pi-pa (L’arte musicale attraverso i secoli – G.Romano)
I popoli mediterranei
Presso i popoli mediterranei, intendo Egizi, Sumeri, Persiani, Ebrei, Cretesi, Greci e Romani, la musica era ampiamente diffusa e ne abbiano certa testimonianza tramite dipinti e bassorilievi: spesso sono raffigurati strumenti musicali, e le esecuzioni accompagnavano circostanze della vita pubblica e privata.
Sin dall’epoca si potevano discernere due diversi generi musicali, la sacra, legata alla religione ed alle cerimonie nei templi, e la profana, destinata ad allietare feste ed intrattenimenti.
Alla musica si attribuivano profondi poteri, che si manifestavano soprattutto durante le cerimonie sacre: il suono veniva percepito come veicolo di contatto con gli dei, capace di influenzare magicamente la realtà. Durante i riti religiosi, i sacerdoti, o dei cantori professionisti, intonavano inni di vario genere, accompagnandoli spesso con strumenti.
Quanto alla musica profana, le tematiche ad essa care non si discostano poi molto dalle attuali: si parlava di amore e di varie vicende della quotidianità. Essa si accompagnava spesso alla danza e faceva uso della voce e di strumenti di ogni genere.
Una menzione a parte merita la musica militare: tamburi, trombe, corni e altri strumenti trovavano largo impiego nelle parate ed in battaglie, per incitare i combattenti.
Purtroppo, per la maggior parte di questi popoli, non ci sono rimasti né brani musicali né documenti scritti che ci illustrino le tecniche di cui essi si servivano.
Solo i Greci ci hanno lasciato informazioni dettagliate sulla loro musica, così che possiamo ricostruirne in modo sufficientemente preciso le loro caratteristiche.
Sembra nessun contributo originale all’evoluzione musicale abbiano fornito i Romani, che hanno ampiamente attinto al sistema elaborato dai Greci.
Nel nostro prossimo appuntamento, ci dedicheremo proprio ad esplorare l’affascinante storia della musica presso questa fiorente civiltà, cui tanti posteri hanno attinto!
Per ascolti e infoemail: sophoshiend@gmail.comBruno Fazzini – tel. + 39 347 1402138 |
|---|
Barbara Pasqualini – Esperta di storia e cultura della musica.
Si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo nel 2004 e dal 2005 al 2008 ha lavorato presso il Dipartimento di Agrobiologia ed Agrochimica della medesima Università, ove ha conseguito un Dottorato di Ricerca in “Genetica e Biologia cellulare”. Al suo attivo ha una pubblicazione scientifica nella branca dell’Epigenetica.
Successivamente è tornata al suo atavico amore, la letteratura, pubblicando nel 2012 il suo romanzo d’esordio: “All’alba, una pioggia di stelle”, Albatros editore. Sta per uscire la sua seconda opera.
Ha sempre coltivato con entusiasmo la sua passione per la musica, sia studiando pianoforte, sia dedicandosi ad approfondire le proprie conoscenze relative al settore della storia della musica nel corso dei secoli.